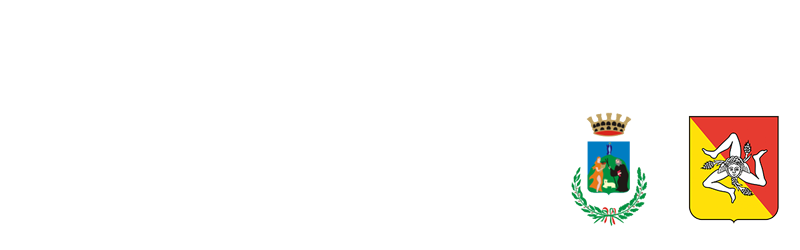Dopo la morte di Guglielmo II il Buono, Enrico VI di Svevia, figlio di Federico Barbarossa, sposò Costanza figlia di Ruggero I e si fece incoronare a Palermo Re di Sicilia nel 1194. Ad Enrico VI successe Federico II, il quale si rivelò uomo saggio, accrebbe i privilegi ai municipi, diminuଠla potenza dei Baroni e, con una grande e geniale riforma dei Parlamenti (che erano stati introdotti in Sicilia dai Normanni) favorଠil popolo. Al Parlamento, dove sedevano allora solo Baroni ed Ecclesiastici, divisi in due bracci, Federico II vi chiamò anche i borghesi e i rappresentanti delle città libere cioè non dipendenti dall’autorità regia. Al Parlamento convocato a Messina nel 1233, Federico classificò Termini tra le Città del Regio Demanio e conferଠil titolo di «Civitas Splendidissima», dato precedentemente dai Romani. Da allora Termini cominciò a mandare al Parlamento i suoi rappresentanti che si chiamarono Sindaci e Procuratori. Dopo Federico II salଠal trono Corrado a cui successe Manfredi, Consigliere particolare del Regno e primo Ministro del Re Manfredi fu Matteo De Thermes, il giovane brillante figlio del Castellano della fortezza di Termini che poi doveva diventare il Beato Agostino Novello Patrono della Città . Matteo di Termini dopo aver compiuto gli studi umanistici in patria, fu mandato a Bologna, per completare gli studi superiori, dove si laureò in diritto civile ed ecclesiastico. Nella battaglia di Benevento, che Manfredi combattè contro Carlo D’Angàò, fu vicino al Sovrano, che cadde valorosamente. Matteo, dopo una grave malattia, distribuଠai poveri i suoi averi, seguଠl’interiore chiamata di Dio e abbracciò da semplice frate laico l’ordine di S. Agostino, prendendovi il nome del Santo fondatore. Visse in umiltà e penitenza e lasciò la Sicilia per raggiungere gli eremi di Siena. Ma non potè restare qui a lungo nascosto. Fu riconosciuto infatti da Giacomo Pagliaresi, già suo compagno di studi a Bologna quando difese il Convento. Il Pagliaresi, fra l’unanime meraviglia dei frati, celebrò il valore di colui che si nascondeva sotto l’umile saio. Riconosciuto con grande suo rammarico per quel che valeva, Frate Agostino fu promosso per ubbidienza al Sacerdozio e assunto dal Beato Clemente, Generale dell’Ordine a collaboratore nel governo. Riformò le regole degli Eremiti dell’Ordine Agostinàano. A Roma fu confessore dei Papi Nicolò IV, Celestino V e Bonifacio VIII. Al Capitolo Generale dell’Ordine tenutosi a Milano, sebbene assente fu unanimemente eletto Superiore Generale. Accettò la carica per imposizione del sommo Pontefice Bonifacio VIII, ma, dopo due anni, a Napoli, al nuovo Capitolo Generale, pregò i confratelli di accettare le dimissioni. Tornò cosଠa Siena. Desideroso di vita umile e nascosto si ritirò nell’Eremo di San Leonardo nelle cui vicinanze costruଠun Ospedale. Morଠil 19 maggio del 1309. Il corpo del Beato Agostino venne traslato a Termini Imerese il 19 maggio del 1977.